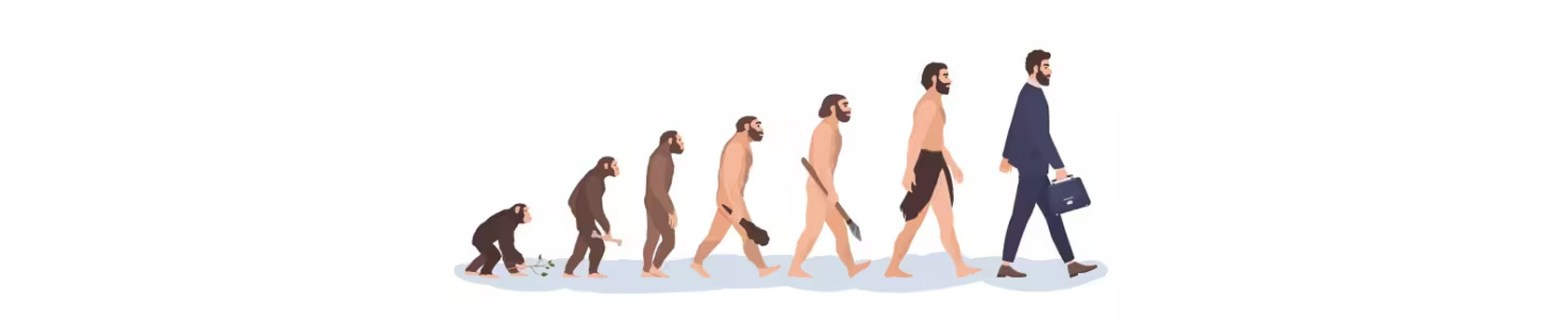- Tiziano. Per certi aspetti siamo stati programmati in questo modo, per fare questo, per fare quello e per decidere di non fare altra cosa in alternativa. Voglio dare un nome al responsabile di questa buffa e originalissima trama. Se c’è un CHI che ci ha programmato, certo non ha programmato me come individuo, con questi occhi, questi piedi, questo carattere e questo spazio esistenziale da gestire, ma ha pensato, inizialmente, a un percorso evolutivo di portata immensamente più ampia nel quale io e altri abbiamo giocato, stiamo giocando un ruolo su una scacchiera della cui architettura non conosciamo lo scopo ultimo e di cui ci sfuggono persino le regole. Ci chiediamo, senza stancarcene, quale sia realmente la meta a cui volge la nostra esistenza individuale, ma molto più pressante sarebbe la domanda rivolta a sapere a che cosa serve, infine, questa cosa complicatissima che definiamo con il termine “evoluzione”. Chissà, questo CHI potrebbe aver impostato un programma inserendovi l’energia, le potenzialità e gli input di un’intelligenza cosmica la quale, nell’ammasso incommensurabile del caos, avrebbe via via stabilito e applicato un sistema necessario di leggi e di regole. Leggi e regole che, per sfrondature successive, avrebbero portato a impostare sistemi di vita, di operatività, di consapevolezza. Tutto questo succede, ora e a partire da qualche centinaio di milioni di anni addietro, sul pianeta Terra. Una briciola invisibile in un Universo inconoscibile, inafferrabile, inconcepibile. Tutto intorno: vuoto, freddo, meccanismo, ordine nel caos. E su questa piccola scheggia, la vita, in solitaria evoluzione. Vogliamo immaginare di scoprire un altro pianeta che ospiti vita organica? Dove mai… Vai a sapere quanti mondi possibili ospitano menti che, rivolto lo sguardo all’insù, si pongono lo stesso problema, quello del perché della vita in questa grande solitudine! Senza che gli uni sappiano degli altri. E quando, fra sette miliardi di anni, poniamo, il nostro sole, trasformato in una supernova, invaderà lo spazio del sistema planetario e, raggiunta la Terra, la farà semplicemente evaporare in una nuvoletta di gas, tutto ciò che l’evoluzione è stata e ha comportato, in centinaia di milioni di anni, sarà annientato, tutto, qui proprio dove ha incontrato le condizioni per realizzarsi, senza che effetto alcuno abbia una qualche risonanza sulle dinamiche del resto dell’Universo, come se nulla fosse mai stato. E, allora, a parte questo nostro minuscolo pianeta dove la scintilla fugace della vita è scoccata ieri, e già sta per esaurirsi, ci sarà qualche angolo dell’Universo dove ha la sua comparsa l’evoluzione biologica, mentale, sociale, tecnologica, di livello tale da lasciare un segno, da trascinare con sé un significato per la globalità intera di “ciò che è”? Oppure tutto si riconduce a una forma di esistenza che è soltanto apparente e che vuole essere una sola, particolare, necessaria espressione di un più complesso sistema pluridimensionale, agente a vari livelli di consapevolezza, verso l’acquisizione di una consapevolezza senza limiti? Ancora: posto che questa consapevolezza debba per qualche ragione acquisire pienezza, essa per chi e da parte di CHI sarebbe imposta? Si potrebbe quasi accettare l’idea che, nel nostro “ora e qui”, non stiamo facendo altro che vivere in una dimensione. Probabilmente proveniamo da altre dimensioni. Allora mi viene di pensare al caso mio particolare, tanto da domandarmi: e se io, individuo, non fossi mai nato? Forse non è mai stato possibile che non nascessi. Dovevo “necessariamente” nascere.
- Tosco. Che intuizione formidabile, Tiziano! Hai scatenato in questa mia testaccia una turbolenza, ma sei riuscito pure ad accendere una scintilla. – State tutti a sentire, vi parlerò un po’ di me. – Mio padre era un produttore di vino, nato e vissuto a Montilla, nella bella, solare, ridente Andalusia. Nel mezzo delle sue frequenti peregrinazioni, per scopi commerciali e di aggiornamento sulle tecnologie che avevano a che fare con il suo lavoro, un bel giorno incontrò mia madre, quella che sarebbe diventata mia madre, quasi per caso. Lei era una splendida ragazza figlia di una famiglia emigrata dalle Filippine. Furono sufficienti pochi giorni di frequentazione e lui, il mio buon papà, se la portò via, in Andalusia. Ma di lì a poco tempo si trasferirono sui colli toscani, in un’azienda vinicola nei pressi di quel gioiello di bellezze antiche che è Pienza. Ed eccomi qui, mezzosangue dagli occhi a mandorla e dalla passione andalusa. – Ora passo a parlare di cose più serie. Dunque mia madre conobbe papà, fra loro s’accese l’amore. Il resto lo fecero le leggi biogenetiche: si fusero insieme un ovulo e uno spermatozoo, poi, trascorsi nove mesi, eccomi a gridare a gran voce la mia sorpresa per la vita e per il mondo che mi accoglie. – Se mia madre non avesse mai conosciuto mio padre? Se si fosse sposata con un ragazzo della sua terra? Certo, ancora quell’ovulo, ma uno spermatozoo differente. Chi sarebbe nato? Io? Non m’importa delle fattezze fisiologiche, mi sto soltanto domandando se in quel corpo, in quel cervello sarei stato io, quell’io che ora e qui sta facendo le questioni che sta facendo. Oppure quell’io non sarebbe apparso per nulla e, al suo posto, sarebbe venuta al mondo una creatura con una consapevolezza tutta sua, della quale io neppure avrei potuto avere notizia perché io non sarei mai esistito? La stessa cosa mi vado prefigurando se papà avesse sposato Amalia, la ragazza andalusa che aveva corteggiato prima di conoscere mia madre. Ma c’è di più. Poniamo che i miei genitori siano proprio quelli che vi ho descritto, dai quali sono nato e poniamo che, portando la moviola indietro di una quarantina d’anni, qualche fortuito evento avesse fatto sì che mio padre e mia madre non fossero stati insieme, diciamo per motivi di lavoro, il giorno in cui in effetti io fui concepito. E poniamo che il concepimento fosse stato rimandato al mese successivo, tanto per lasciare possibilità a una nuova ovulazione. I miei predecessori gameti avrebbero recato con sé il medesimo patrimonio genetico, non vi pare? Ma ne sarei scaturito io? Oppure un altro io che con questa mia consapevolezza dell’ora e qui avrebbe avuto proprio nulla a che fare? Se è vero, Tiziano, che dovevamo necessariamente nascere, e qui mi ricollego a quel che ha detto poco fa Almach a proposito dell’identità vista con gli occhi del Filosofo, allora non me la sento di pensare agli individui raziocinanti come a tanti semi di un albero che, trasportati dal vento, cadono nella terra e germogliano oppure, per volere della sorte, vengono ingoiati dagli uccelli o vanno a finire nella corrente di un fiume per disperdersi e dissolversi nel vasto oceano e confondersi con le sue acque senza speranza di dare attuazione vitale ai geni fin là trasportati.
- Almach. Perdonami, Tosco, se t’interrompo. Vorrei riprendere il filo lasciato un po’ in sospeso, ma mi sbrigo in poco tempo. E allora chiamo ancora in causa Emanuele Severino nel momento in cui afferma che il soggetto, la cosa, che egli chiama “essente”, è, dunque non può essere soggetto al divenire; poiché è, non può trasformarsi in altro da sé; è in quanto rientra nel concetto più ampio di “eternità”, per il quale gli è impossibile non essere; è nell’eternità, per il motivo che non proviene da un processo che lo tragga dal nulla e al nulla lo riporti. “Il destino dell’essente” – cito da Emanuele Severino – “è l’impossibilità del divenir-altro, cioè è l’eternità dell’essente”. Il Filosofo alle cui teorizzazioni mi sto qui appoggiando pone l’esistenza di una “struttura originaria del destino” e fa menzione di un “piano originario” nel quale sarebbe immersa la totalità degli elementi. A questa struttura originaria del destino apparterrebbe l’eternità di ogni essente e del suo apparire. Sto riferendo di una costruzione concettuale che non può evitare di riportare la mia mente a quell’idea di struttura, di piano che altre volte abbiamo abbinato al concetto di “intenzione” ravvisandovi nella loro coniugazione consapevole l’espressione di una Volontà superiore, infinita, inarrivabile e ineffabile. La provocazione con la quale Emanuele Severino chiude la propria opera[1] è di gran lunga stimolante nel tentativo di cercare una conclusione soddisfacente agli interrogativi incontrati per via: chissà, lo stesso divenire di cui siamo spettatori e testimoni, giorno dopo giorno, potrebbe essere “il sopraggiungere e lo scomparire degli eterni”.
- Tosco. Bene, ora torno a me. Voglio dire, mi sembra un po’ strano pensare che la natura abbia dato inizio all’esistenza di un corpo umano e un pio giardiniere abbia preso, da un immenso contenitore, una coscienza assopita e inerte per innestarla nel cervello di quell’essere e attivarla e farla crescere come il seme sprofondato nella terra fertile. – Ma, se poi riporto l’esempio al mondo animale, neppure lì trovo una spiegazione esauriente. Eppure fra gli animali l’individualità è qualcosa di tangibile e che può destare un certo interesse, a motivo dei ricorrenti parti plurigemini. – Eccomi all’esempio, non allarmatevi. – Avevo un cane, era una femmina, un bellissimo esemplare di “collie” dal pelo sfumato color fulvo. Un giorno la “Lady”, questo era il suo nome, conobbe Pippo, un pastore scozzese bianco e nero, elegantissimo. Si maritarono alla moda dei cani e dal loro breve idillio nacquero sei meravigliosi cuccioli, quali bianchi e neri, quali fulvi. – E ora la riflessione: erano nati tutti da un’ovulazione unica, poi non so se gli ovuli della Lady furono proprio sei o meno; voglio dire, si sarebbe potuta essere verificata una, o più di una, fecondazione monozigotica contemporaneamente ad altre dizigotiche. Ora sto pensando al corredo cromosomico. I geni e i loro cromosomi presenti sia negli ovuli della Lady sia nei gameti maschili di Pippo appartenevano, rispettivamente, a individui singoli, avrebbero dunque dovuto riportare il medesimo corredo. Ma non è così, perché uno dei cuccioli, che chiamammo Flock, era diverso da tutti gli altri, era affettuoso fin da piccolino, cercava il nostro interessamento, sembrava quasi ci conoscesse già prima di essere nato. Tant’è che cinque suoi fratelli furono venduti o regalati ad amici, ma Flock lo tenemmo per noi a motivo del suo particolare attaccamento e questo suo carattere fu mantenuto sino all’età adulta. Che viene a dire tutto ciò? Viene a dire, semplicemente, che quei sei cagnolini erano gemelli, scaturiti dalla medesima fonte genetica, ma ognuno di loro possedeva una propria individualità già ben definita alla nascita e riconoscibile via via che il tempo avanzava. Ora mi chiedo, se mi concedete di attribuire a Flock un barlume di autoconsapevolezza animale, che secondo me è il corrispettivo del sentire rispecchiata la propria identità e del riconoscersi, da parte del cane, in un certo tipo di atteggiamenti che una persona – il suo padrone – va sviluppando nei suoi confronti, mi chiedo: che cosa sarebbe stato di Flock se quei due gameti, proprio quei due che si sono incontrati e che hanno dato origine alla sua esistenza, avessero seguito strade diverse? Ma è tutto inutile, perché la domanda dovrebbe porsela Flock stesso, e lui non pensa o, almeno, non utilizza qualche forma di pensiero al livello nostro. Avrà sperimentato, nel suo cervellino, in qualche misura un pizzico di autopercezione? Anche lui è venuto alla luce trascinato dalla corrente impetuosa di una necessità? Doveva per forza esserci nel mondo? – Vedete, ora ho compiuto il giro del cerchio e sono tornato al punto di partenza. Sì, perché da quanto vado ragionando mi sento autorizzato a supporre che la mia autoconsapevolezza, l’autoconsapevolezza di ciascuno di voi che mi state ascoltando, non solo, ma di tutti gli esseri raziocinanti e da sempre, sia un “unicum” indivisibile. Io in voi, voi in me, noi in tutti e tutti in noi. Già, ho anche detto che il cerchio si è chiuso. Si chiude e si riapre per il motivo che mi vado anche interrogando su che cos’era tutta questa realtà, attorno alla quale stiamo discorrendo, prima che ci accorgessimo di essere al mondo. E, se la cosa non vi disturba troppo, che cosa sarà quando saremo noi stessi, in quanto individui percipienti noi stessi, a chiudere gli occhi al mondo. Angoscia, una grande profonda assordante angoscia che nessuna rivelazione rivelata, nessuno giro di parole, nessun potere d’immaginazione, nessuna promessa gravida di fallaci garanzie può portare a consolazione.
- Sirrah. Ma è tutto così, in natura. Prendi soltanto il calabrone, per fare un esempio grezzo e banale. È un imenottero pericoloso, lo sappiamo bene, apparentemente superfluo nel ciclo della vita. Ci sarebbe proprio da domandarsi: a che cosa serve? Ma anche quell’insetto insignificante sta lì perché c’è un motivo: è anch’esso una nota che fa parte della sinfonia dell’universo; una nota che non percepiamo nel suo contributo alla composizione generale, così come non avvertiamo con l’udito le frequenze degli ultrasuoni o non vediamo con gli occhi le bande estreme dello spettro elettromagnetico. Una nota soltanto, ma provaci a eliminarla… Io stessa sono una nota della sinfonia dell’universo. Lo stesso Kierkegaard lo dice con parole che suscitano commozione: “… io sono un filo che dev’essere intessuto nella trama della vita!”. Allora dovevo esserci. D’altra parte, mutando ambiente di pensiero, mi viene da pensare a Giordano Bruno il quale riporta il concetto del “perché c’è” al senso dell’immortalità. Mi spiego meglio: Giordano Bruno, ragionando sull’immortalità, si muove ben lontano dall’idea di un semplice annichilimento dei singoli soggetti al termine della loro vita, mentre vede più di buon grado un processo di trasformazione che interessa ogni vivente verso altre forme viventi del tutto nuove. E così anche il Flock di Tosco doveva per forza esserci nel mondo e non perirà, ma si trasformerà.
[1] Emanuele Severino, L’identità della follia, Cit. pag. 372.
Immagine di Copertina tratta da Focus.